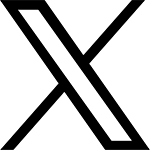Per la nostra rubrica Socialmente bello, incontriamo Patrizia Fiocchetti: attivista femminista dagli anni ’70, con una vita trascorsa accanto alle donne nei luoghi più complessi del mondo. Oggi, come referente legale del progetto SAI Gea e dell’area gender di Arci Solidarietà, porta nel suo lavoro uno sguardo internazionale e una profonda esperienza umana, sostenendo ogni giorno donne migranti che affrontano violenze, discriminazioni e percorsi di rinascita. Con lei abbiamo parlato di attivismo, sorellanza, educazione e libertà: una conversazione potente, da leggere soprattutto con gli occhi delle nuove generazioni.
Patrizia come hai iniziato il tuo percorso come attivista femminista e cosa ti ha spinta a impegnarti soprattutto nella difesa delle donne migranti?
Dunque, il mio percorso nasce da molto lontano: già nella seconda metà degli anni ’70 ero attiva nel movimento femminista italiano. Ero molto interessata, oltre che alle politiche italiane che si stavano evolvendo in quel periodo, anche a una visione più internazionale, che offriva spunti molto interessanti, soprattutto per il superamento del cosiddetto femminismo bianco occidentale. Non guardavo soltanto agli Stati Uniti e al Black Feminism, ma ero attratta soprattutto da quei Paesi meno conosciuti, in particolare nel Sud del mondo, dove esistevano realtà antiche e molto stimolanti anche per noi donne occidentali. Ho iniziato ad avvicinarmi a questi contesti in vari modi, anche con un attivismo diretto, partecipando in prima persona in luoghi come l’Iraq e l’Iran, quando ero ancora molto giovane. Col tempo, il mio impegno si è evoluto, spostandosi in altri scenari di crisi, ma sempre mantenendo un punto fermo: osservare e sostenere il protagonismo delle donne, che in molti di questi luoghi andava oltre la semplice rivendicazione di diritti e diventava un vero e proprio motore di cambiamento sociale e politico.
Diciamo che in queste tue esperienze, sin da giovanissima, hai acquisito uno sguardo molto ampio, internazionale, che sicuramente ti sei portata dietro anche nel tuo lavoro attuale con Arci Solidarietà, nel sistema di accoglienza e integrazione per persone con background migratorio. Lavorando in questo contesto, ti chiedo: quali sono le difficoltà principali che affrontano le donne migranti quando arrivano in Italia? E soprattutto, si parla spesso di violenze e discriminazioni multiple: ci puoi spiegare cosa significa e se lo ritrovi nel tuo lavoro quotidiano?
Sì, rispondo proprio all’ultima parte della domanda, perché è centrale in quello che dirò. Nel mio lavoro quotidiano ritrovo tantissimo questo concetto. Le problematiche che le donne portano con sé sono diverse, complesse, e si originano sia dai Paesi di provenienza che dal percorso migratorio che affrontano per arrivare in Europa, e in particolare in Italia. Queste problematiche cambiano a seconda dell’area geografica, del contesto sociale e politico da cui provengono, e anche del fatto che abbiano scelto o siano state costrette a partire. Essendo la questione molto ampia, cercherò di sintetizzarla in due grandi gruppi, anche se ovviamente ogni donna ha un vissuto personale, unico, e nel nostro progetto SAI lavoriamo proprio su interventi individualizzati, costruiti sulla specificità di ogni storia. Il primo gruppo comprende donne provenienti dall’Africa subsahariana, in particolare dalla Nigeria. Queste donne hanno spesso alle spalle esperienze drammatiche: abusi, matrimoni forzati e precoci, mutilazioni genitali femminili. Nella stragrande maggioranza dei casi, direi nel 99%, sono vittime di tratta sessuale. Il viaggio che intraprendono è spesso traumatico: passano attraverso il Niger e soprattutto la Libia, dove vengono detenute in veri e propri centri di prigionia, subendo ulteriori violenze, anche gravi. Quando arrivano in Italia, finiscono nella rete dei trafficanti e vengono sfruttate. Spesso hanno con sé bambini, e quando le accogliamo nei nostri progetti hanno già iniziato, con grande fatica, il percorso di uscita dalla tratta. Sono donne che portano dentro una sofferenza immensa, spesso iniziano il viaggio da giovanissime, a volte ancora minorenni. Eppure, ciò che colpisce è la forza, la voglia di riscatto, la determinazione a conquistare l’autonomia, nonostante le difficoltà e il carico familiare. Lavorare con loro richiede attenzione, delicatezza. È fondamentale evitare ogni giudizio e offrire un ascolto reale: è questo il primo strumento del nostro lavoro. Il secondo gruppo è composto da donne attiviste politiche, che arrivano da Paesi come l’Iran o l’Afghanistan. Sono donne che hanno una forte coscienza politica, che hanno lottato per i diritti e la giustizia e che, proprio per questo, sono state perseguitate, incarcerate, torturate. In molti casi sono state costrette alla fuga e alla migrazione. Anche loro portano con sé esperienze di grande sofferenza, ma anche una visione del mondo estremamente lucida e potente.
Come dicevi bene prima, gli strumenti del mestiere di chi lavora nel sociale, come hai detto bene, sono l’ascolto, la sospensione del giudizio, l’accoglienza dell’unicità e delle storie che ogni persona porta con sé. In questo contesto, partendo dalla tua vasta esperienza – che ha segnato la tua vita sia come donna che come professionista – che differenze vedi, se ci sono, tra le storie di violenza vissute dalle donne migranti di cui hai parlato, e quelle delle donne italiane, nate e cresciute nel nostro paese?
È una domanda molto interessante e anche molto importante. La prima cosa che voglio chiarire è che le forme di violenza – fisica, economica, psicologica, di controllo – sono trasversali. Non sono legate al colore della pelle, alla religione, al livello economico o all’estrazione sociale. La violenza ha sempre come attore un uomo, e questo uomo può avere qualsiasi identità. Certo, possono cambiare alcune pratiche. Ad esempio, nel caso delle donne nigeriane vittime di tratta, c’è il cosiddetto rito juju, una sorta di voodoo, che viene utilizzato per tenerle sotto controllo attraverso la paura. Ma il meccanismo di fondo, quello del dominio e del controllo sull’altro, è lo stesso. Quello che cambia, però, è la conoscenza degli strumenti che si possono avere per uscire da queste situazioni. Molte donne migranti non conoscono i loro diritti, non sanno che è possibile denunciare, non hanno mai avuto un’educazione in tal senso. E poi c’è la paura, un sentimento molto diffuso e comprensibile. Ma anche la società che accoglie non aiuta: molto spesso ha atteggiamenti stigmatizzanti. Ti faccio un esempio. Quando una donna migrante, per esempio nigeriana, si presenta per denunciare una violenza, può accadere che venga immediatamente etichettata: “sei nigeriana, quindi sei una prostituta”. Questo crea un ostacolo enorme al riconoscimento della sua esperienza e al suo percorso di autodeterminazione. La violenza non conosce confini. Ma ciò che davvero può fare la differenza è fornire a tutte – indipendentemente da nazionalità, provenienza, documentazione –gli strumenti legali, informativi, culturali per potersi difendere, denunciare, uscire dalla violenza. Questo è, secondo me, il cuore del nostro lavoro, sia nei centri antiviolenza sia nei progetti di accoglienza come il nostro.
Tornando alla tua esperienza anche sul piano internazionale, tu hai un legame personale molto forte con l’Iran. In questi anni abbiamo seguito, sostenuto e ammirato la lotta delle donne iraniane, in particolare con il movimento “Donna, Vita, Libertà”. Cosa ci ha insegnato questa lotta? E cosa possiamo portare nelle nostre pratiche quotidiane?
Sì, è vero. Ho un legame molto forte con l’Iran. La mia esperienza con le attiviste iraniane risale alla seconda metà degli anni ’80. Erano donne incredibili, coraggiose, determinate. Vorrei ricordare che le prime a scendere in piazza contro il regime di Khomeini, non appena salito al potere, furono proprio loro: era l’8 marzo 1979. Erano studentesse, professioniste, donne impegnate, che si rifiutavano di accettare l’obbligo del velo. È stato un atto di enorme coraggio. Moltissime di loro furono arrestate, torturate, e alcune sparirono nel nulla. Ma quello è stato l’inizio di un movimento che non si è mai fermato. Le donne iraniane che ho conosciuto sono donne che hanno pagato prezzi altissimi per il proprio impegno: la tortura, il carcere, l’esilio. Eppure, hanno continuato a portare avanti una visione di libertà e giustizia. Il movimento “Donna, Vita, Libertà” nasce dall’assassinio di Mahsa Amini, uccisa dalla polizia morale perché portava il velo in modo considerato “non corretto”. Ma in realtà, quella morte ha fatto esplodere una situazione che era già in ebollizione. L’Iran è un Paese giovane, con una società molto critica verso il regime. E le donne non stanno lottando solo per i propri diritti: **si fanno portatrici delle istanze di un’intera popolazione** che vuole libertà. Hanno usato il proprio corpo come strumento di lotta: si sono fotografate di spalle, con i capelli sciolti, sfidando apertamente i Pasdaran. È stato un gesto potentissimo. Perché quando si tolgono i diritti alle donne, si tolgono anche agli uomini. L’intera società ne viene colpita. E questo è un insegnamento che vale per tutte noi.
Hai citato anche il Rojava, dove le donne sono state protagoniste dell’autogoverno femminista. Cosa ti ha colpito di più di questo progetto politico e umano e in che modo hanno reso concreto l’insegnamento di Öcalan, leader curdo, il quale sosteneva che “nessuna società può dirsi libera finché le donne non sono libere” ?
Sono stata due volte in Rojava. La prima volta nel 2015, poco dopo la fine dell’occupazione di Kobane da parte dell’ISIS. Kobane era completamente distrutta: palazzi devastati, ordigni inesplosi nelle case, fumo dei bombardamenti ancora visibile all’orizzonte. I combattimenti erano ancora in corso, poco distanti. Eppure, nonostante quella devastazione, il monito di Öcalan era già stato messo in pratica. Uno dei pilastri di quel modello è proprio il protagonismo femminile. Le donne curde hanno avuto – e hanno – un ruolo fondamentale nella ricostruzione del tessuto sociale, politico ed economico. In Rojava, le donne non sono state messe da parte, come spesso accade nelle rivoluzioni. Non hanno detto “ci occupiamo delle donne dopo la liberazione”. No, lì si è deciso che la questione femminile sarebbe stata centrale prima, durante e dopo. Ricordo che incontrammo alcune delle responsabili del movimento femminista: ci raccontarono che, pur in una situazione di emergenza assoluta, stavano già ricostruendo i comitati di donne nei quartieri, per stare accanto alle famiglie che tornavano, per sostenere le donne nei conflitti familiari, per parlare anche con gli uomini. Era un lavoro di trasformazione culturale, profondo, radicato. Questo, per me, è stato un grande insegnamento. La liberazione femminile non si può rimandare. Va agita, vissuta, costruita insieme alla trasformazione della società.
Questo mi fa pensare al concetto di sorellanza internazionale. Che cosa significa per te, concretamente, costruire un’alleanza tra donne di culture e storie diverse?
Per me è stato qualcosa di molto concreto e prezioso. La vita mi ha dato l’occasione di conoscere donne straordinarie, provenienti da contesti diversissimi, ma con le quali ho condiviso una profonda affinità. Posso dire che ci sentivamo come le dita di una mano – una mano enorme, con tantissime dita – tutte diverse, ma che lavoravano insieme. Le differenze tra noi – culturali, fisiche, caratteriali – non erano un ostacolo. Anzi, le attraversavamo con rispetto, e anche con confronti accesi, perché c’era fiducia e affetto reciproco. La sorellanza, per me, è questo: lavorare per la crescita comune. Accompagnare una donna nella crescita significa crescere tutte insieme. In una società come la nostra, che spinge verso l’individualismo e spesso mette le donne in competizione tra loro – anche da adolescenti, a scuola, per l’aspetto fisico, per chi viene scelta da un ragazzo – è fondamentale rompere questa dinamica e costruire sostegno reciproco.
Cosa può fare la scuola italiana per aiutare ragazzi e ragazze a emanciparsi da questi modelli stereotipati, da questa cultura che può sfociare nella violenza di genere e nella cultura dello stupro?
Questa domanda mi fa sorridere amaramente, perché mi sembra quasi assurdo doverla ancora fare oggi. L’educazione sessuo-affettiva era una delle battaglie delle femministe negli anni ’70. Eppure, ancora oggi, non è stata pienamente introdotta nelle scuole. La scuola deve fornire strumenti, innanzitutto, per riconoscere e decostruire gli stereotipi. Deve aiutare i ragazzi e le ragazze a capire, a riflettere, a costruire relazioni basate sul rispetto delle differenze, perché non siamo tutti uguali, ma dobbiamo essere uguali nei diritti. Credo anche che sia fondamentale portare testimonianze dirette nelle scuole. Io l’ho fatto molte volte, attraverso i miei libri e i miei viaggi. Ho raccontato le storie delle donne iraniane, afghane, curde, delle donne migranti. E ho trovato un ascolto attento, partecipe, sia nelle scuole medie che superiori. I ragazzi e le ragazze hanno bisogno di confronto, di voci diverse. È così che si aprono le menti e si costruisce la possibilità di agire il cambiamento.
Questa intervista sarà letta principalmente da studenti e studentesse, perché è importante che anche loro si interessino e agiscano contro la violenza sulle donne? E per chi volesse diventare attivista, quali sono i tuoi suggerimenti?
È importante perché attraverso questo impegno si conquista la propria individualità. Alle ragazze vorrei dire: siete forti. Non lasciate che nessuno vi convinca del contrario. Informatevi, leggete, cercate modelli di donne autonome, libere. A noi donne, spesso, viene insegnato che ci sono dei limiti davanti a noi. Ma non è vero. Io stessa ne ho superati tanti: fisici, psicologici, culturali. E si può fare, a qualsiasi età. Ma è necessario prepararsi, formarsi, credere in sé stesse, e – soprattutto – stare vicine le une alle altre. Ai ragazzi dico: formatevi anche voi, informatevi. Ribellatevi agli stereotipi che vi impongono di essere in un certo modo. Anche voi siete vittime di una cultura che vi reprime. Quando un ministro dice che “gli uomini sono fatti così”, io da uomo mi sentirei offeso. Significa essere ridotti a uno stereotipo. E invece si può essere diversi, si può crescere insieme, si può diventare alleati delle proprie compagne. Ci sono tante realtà in cui potersi attivare: i circoli Arci, i centri antiviolenza che fanno formazione. Basta guardarsi intorno. Il problema è che spesso i giovani abbassano lo sguardo, restano chiusi nel proprio individualismo. Ma alzare lo sguardo è la prima forma di forza, individuale e collettiva.
Una battuta finale. C’è una frase che mi ha sempre molto colpita: “Ammirare altre donne è determinante per essere sé nel mondo. Noi troviamo casa quando qualcosa che ci appartiene lo riconosciamo in un’altra.” Cosa ne pensi?
Quando l’ho letta, mi sono venute in mente tutte le donne che ho conosciuto, che ho ammirato e che continuo ad ammirare. Sono donne che mi hanno fatto crescere, che mi hanno fatto cambiare, che mi hanno insegnato a vedere ogni donna – nel bene e nel male – come una sorella. Ammirare un’altra donna non ci toglie nulla. Anzi, ci rafforza. Non parlo solo di figure storiche ma anche di donne che incontriamo nel quotidiano. Ogni donna che ho incontrato mi ha lasciato qualcosa. Ogni pezzo l’ho fatto mio. E spero, nel mio piccolo, di aver lasciato anch’io un pezzo di me in qualcun’altra.