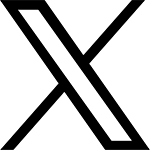In un tempo in cui le distanze sembrano aumentare e le differenze diventano barriere, l’università può diventare un ponte. Per questo, nella rubrica Socialmente bello, ho intervistato il professor Domenico Dursi, lucano di nascita, docente di Diritto romano alla Sapienza di Roma, protagonista di un progetto unico: una “facoltà congiunta con la Zhongnan University of Economics and Law” di Wuhan, in Cina. Tra codici giuridici, visioni del mondo e studenti di domani, ci racconta un’esperienza che unisce due universi solo in apparenza lontani – e ci aiuta a guardare con occhi nuovi il futuro.
Professore, ci racconta come nasce questa avventura che l’ha portata da Roma a Wuhan?
L’avventura nasce ormai alcuni decenni fa, da una serie di progetti di collaborazione tra studiosi di Diritto romano e studiosi cinesi, impegnati in un momento storico decisivo: la codificazione del Diritto civile in Cina. Molti giovani ricercatori cinesi venivano in Italia per confrontarsi con i nostri esperti, in particolare con il professor Diliberto e il professor Schipani, che hanno dato avvio a questo percorso. Da lì siamo passati a una nuova fase: finita “l’età della codificazione”, si è cominciato a formare la nuova generazione di giuristi.
Come riesce una grande università europea come La Sapienza a dialogare con un ateneo cinese come quello di Wuhan? E da questo dialogo, cosa nasce?
All’inizio non è stato semplice: ci trovavamo di fronte a due strutture amministrative molto diverse, ognuna con punti di forza e anche punti di debolezza. Ci sono stati momenti complessi, ricordo incontri tra funzionari italiani e cinesi che sembravano venire da pianeti diversi. Ma la volontà di far funzionare il progetto è stata forte, ed è arrivata anche dall’alto, dalle governance dei due atenei. Le attività sono iniziate tra le due facoltà di Giurisprudenza e hanno portato alla nascita, a Wuhan, di una facoltà congiunta tra la Sapienza e la Zhongnan University of Economics and Law. Qui formiamo studenti che sono a tutti gli effetti iscritti alla Sapienza, anche se studiano in Cina. Le differenze culturali sono tante. Ai miei studenti italiani faccio spesso un esempio: è come se per millenni due mondi fossero andati avanti su binari paralleli, senza mai toccarsi. Finalmente si sono incontrati. È un po’ come se scoprissimo che su Marte c’è vita intelligente: esseri che ci somigliano, ma che non abbiamo mai incontrato. E allora scopriamo modi diversi di vivere, pensare, vedere il mondo. Questo confronto, per me, è stato un modo per relativizzare : smettere di pensare che il nostro sia l’unico punto di vista possibile.
La Sapienza, quindi, è stata pioniera in questo tipo di collaborazione?
Assolutamente sì. La facoltà congiunta con la Zhongnan University è un unicum nel panorama universitario italiano, ma anche europeo. E non è tutto: oggi, alla facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, ospitiamo anche la più grande biblioteca di diritto cinese fuori dalla Cina , in termini di volumi. Un patrimonio unico.
Parliamo ai ragazzi delle scuole superiori, che presto sceglieranno se e come proseguire gli studi. La Cina spesso viene percepita come lontana, misteriosa. Lei che la conosce da vicino, cosa può dirci della vita quotidiana dei giovani cinesi? Sono davvero così diversi dai loro coetanei italiani?
Le differenze ci sono, certo. Ma ci sono anche molti punti in comune. Negli ultimi trent’anni, la globalizzazione e le politiche di apertura della Cina hanno intensificato gli scambi. Questo ha portato a una certa condivisione di modelli culturali, anche tra giovani. Detto ciò, nella mentalità dei ragazzi cinesi rimane qualcosa di profondamente radicato nella tradizione. Ma non è un ostacolo al dialogo: al contrario. Direi che, usando un vecchio slogan, la Cina è vicina. Ogni anno migliaia di studenti cinesi scelgono di studiare in Italia – e molti italiani partono per la Cina. Solo lo scorso anno, il governo cinese ha messo a disposizione mille borse di studio aggiuntive per studenti universitari italiani. È un segnale forte.
Le comunità cinesi in Italia sono spesso percepite come chiuse, con poche interazioni con il resto della società. È davvero così? E scuola e università possono avere un ruolo nell’aprire nuovi legami e culture condivise?
È una domanda complessa. Paradossalmente, conosco meglio i cinesi che vivono in Cina che le comunità cinesi in Italia. Posso però dire una cosa generale: tutte le comunità migranti – come accadeva agli italiani all’estero – tendono a proteggersi, a costruire regole proprie, almeno inizialmente. Detto questo, la comunità cinese in Italia mi è sempre sembrata molto collaborativa , pronta a integrarsi nel tessuto sociale, economico e culturale del nostro Paese. Ma ripeto: è un’impressione generale, perché non ho una conoscenza diretta e approfondita.
Ci sono giovani della comunità cinese presente in Italia che studiano in Sapienza, a Roma?
Sì, ne conosco diversi. Alcuni sono seconde generazioni, nati e cresciuti in Italia. Altri sono arrivati da piccoli, a sette o otto anni. Sono perfettamente integrati. Italiani a tutti gli effetti, per cultura e visione della vita. La comunità cinese che conosco ha una fortissima voglia di integrarsi.
Lei insegna Diritto romano, cioè le basi del nostro modo di pensare la giustizia e la convivenza. Cosa significa portare questi concetti in un Paese come la Cina, dove la storia e la cultura giuridica sono molto diverse?
È una domanda molto interessante, che meriterebbe quasi una lectio magistralis, ammesso di esserne in grado. Provo a sintetizzare. Il Diritto romano è uno degli elementi costitutivi del pensiero occidentale. Ricordo, a tal proposito, il dibattito sulla Costituzione europea — poi abortita — in cui si discuteva delle sue radici giudaico-cristiane. Io credo, da laico convinto, che quelle radici esistano, ma che vadano affiancate ad altre due fondamenta imprescindibili: la filosofia greca e, appunto, il Diritto romano. Ora, perché il Diritto romano può essere utile in un mondo, come quello cinese, che ha una propria millenaria cultura giuridica? Le ragioni sono molteplici. Innanzitutto, la tradizione giuridica cinese è prevalentemente una tradizione di diritto penale. I rapporti tra privati, invece, venivano storicamente regolati da consuetudini o da riti di matrice confuciana. Il Diritto romano, al contrario, ha sviluppato una elaborazione altissima del diritto privato, soprattutto a partire dal momento in cui il ceto dei giuristi si laicizza, cioè si rende autonomo dai sacerdoti. Da lì nasce una separazione tra diritto e morale, che è di grande attualità ancora oggi. Questa autonomia ha permesso al giurista romano di specializzarsi, creando regole e protocolli di interazione tra privati che garantissero, da un lato, uguaglianza nelle relazioni e, dall’altro, certezza nelle situazioni giuridiche. Ed è proprio questo che, a mio avviso, interessa oggi alla Cina: da una parte, garantire l’equilibrio negli scambi giuridici e commerciali; dall’altra, costruire congegni normativi che assicurino la prevedibilità dei comportamenti privati e delle loro conseguenze. C’è poi anche un motivo di ordine geopolitico. Il Diritto romano ha avuto una capacità di espansione notevole, simile a quella del latino: dal latino sono nate le lingue neolatine, che pur nella varietà conservano una base comune. Allo stesso modo, il Diritto romano ha forgiato categorie, concetti e un linguaggio giuridico che ha dato origine ai cosiddetti diritti neoromani, che condividono un humus comune.
Faccio alcuni esempi:
In Germania, non si parla una lingua neolatina, eppure il diritto è chiaramente neoromano. In Russia, idem: “zar” deriva da “cesar”, ed è un segno profondo della romanizzazione. In Giappone, e oggi anche in Cina, dopo un percorso durato più di vent’anni e culminato con la promulgazione del nuovo codice civile, si è giunti a un sistema giuridico di tipo neoromano. Chi studia o contribuisce a costruire un sistema giuridico basato su queste fondamenta ha, di conseguenza, una maggiore capacità di dialogo con altri ordinamenti. Una capacità superiore, ad esempio, rispetto a quella offerta dal sistema di Common Law, che è proprio degli ordinamenti anglosassoni (come quello statunitense, inglese o indiano), ma meno esportabile e meno “traducibile” su scala globale.
Studiare all’università, in Italia o in Cina, è anche un modo per costruire il futuro di una società. Come vede il ruolo dei giovani nella costruzione di un mondo più giusto e cooperativo tra i popoli?
Il ruolo dei giovani è fondamentale. Sono ancora capaci di sognare, di immaginare un mondo diverso. Col tempo, questa capacità rischia di spegnersi. Ma se vogliono davvero cambiare le cose, i giovani devono studiare. Gramsci diceva Studiate, perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. E aveva ragione. Quelle parole sono ancora attualissime.
La Cina è spesso raccontata come un modello di sviluppo rapidissimo, ma anche segnato da forti contrasti. Da osservatore diretto, quali cambiamenti sociali l’hanno colpita di più negli ultimi anni?
Quello che colpisce di più è l’emergere di un ceto medio urbano, in continua espansione. È un cambiamento visibile, profondo. Ed è un paradosso se pensiamo a cosa accade in Europa, dove il ceto medio si restringe. Ma per capire la Cina, serve cambiare prospettiva. Non possiamo leggerla con le nostre categorie.
Molti giovani italiani sognano di studiare all’estero, ma raramente pensano alla Cina. Perché invece potrebbe essere una scelta interessante anche per capire meglio il mondo di oggi?
Perché la Cina è una cultura millenaria, elaboratissima, fatta di riti, di gesti, di rispetto. Studiare lì aiuta a relativizzare. Per esempio, noi beviamo acqua fredda a tavola. I cinesi bevono acqua calda. Sono piccoli gesti che raccontano visioni del mondo differenti. E imparare a convivere con le differenze è l’unico modo per resistere ai fondamentalismi.
La tecnologia in Cina è ovunque e molto avanzata. Questo cambia anche il modo di studiare, pensare, relazionarsi?
Sì, assolutamente. In Cina oggi si paga solo con app. Carte di credito o contanti sembrano preistoria. Questo impatta anche sul mondo universitario: gli studenti hanno una dimestichezza digitale altissima. Certo, c’è anche il rischio di un uso eccessivo della tecnologia. Ma va governata, non rifiutata. Ancora una volta, Gramsci, riflettendo sui luddisti, rilevava come non bisognasse distruggere le macchine, ma usarle per migliorare la condizione umana.
Dopo tanti anni tra Roma e Wuhan, cosa la sorprende ancora della Cina? E cosa porta con sé da La Sapienza nel suo lavoro lì?
Mi sorprende la loro capacità di pensare in termini collettivi , la voglia di rimettersi in gioco, la fiducia nel futuro. Parlano di generazioni, di responsabilità condivise. È un approccio comunitario, non individuale. Da La Sapienza porto il rigore, la serietà, il valore del confronto scientifico. E porto anche il fascino di un’università che è un’eccellenza italiana nel mondo.
Per concludere: un messaggio per i ragazzi e le ragazze che ci leggono su Zai.net?
Andate in Cina. Se avete curiosità, iniziate a studiare il cinese. È la lingua più parlata al mondo. La Cina non è chiusa, come spesso si racconta. È una società attrattiva, attenta, dinamica. Ogni anno offre borse di studio per italiani, africani, studenti di tutto il mondo. Studiare lì significa vivere un’esperienza internazionale completa, che cambia il vostro modo di guardare tutto il resto. E dopo, andare in Germania o in Francia vi sembrerà quasi come restare in Italia.