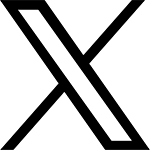Il 2025 è quasi terminato e a questo punto è evidente che l'Intelligenza Artificiale sia stata forse la tematica più dibattuta dell'anno -insieme al genocidio di Gaza. Sebbene gran parte della popolazione non abbia ancora un'idea chiara di che cosa sia effettivamente l'IA, come funzioni e in quali ambiti possa essere utilizzata in modo efficace, l'attenzione è orientata soprattutto verso i rischi che questa nuova frontiera tecnologica potrebbe comportare. Questo accade in Italia, mentre in altri luoghi del pianeta l'approccio è decisamente più fiducioso: la Cina, ad esempio, si sta impegnando ormai da anni per diventare leader globale di IA, e per raggiungere questo obiettivo ne sperimenta le potenzialità da tempo. Talvolta anche attraverso modalità singolari, come nel caso delle fasce che rilevano l'attenzione degli studenti.
Le classi sperimentali fuori Shanghai
Nel 2019 alcune classi elementari erano state coinvolte in uno dei più grandi esperimenti al mondo sull'uso dell'IA nel contesto scolastico. Si trattava di un progetto da miliardi di dollari volto ad incrementare il rendimento scolastico dei bambini e, parallelamente, fornire dati a potenti algoritmi. I giovani studenti venivano muniti di una fascia da indossare sulla fronte durante le ore scolastiche: la fascia, dotata di tre elettrodi, analizzava il livello di attenzione dello studente, trasmettendo i dati in tempo reale all'insegnante, che avrebbe poi condiviso un report sulla chat di gruppo dei genitori. Il funzionamento del device, tuttavia, non poteva considerarsi completamente attendibile, in quanto la tecnologia utilizzata, l'elettroencefalografia (EEG), è nota per essere soggetta ad artefatti, cioé a risultati fuorvianti: ad esempio, la reazione a un improvviso prurito avrebbe potuto essere rilevata come mancanza di attenzione. Il rendimento della classe era comunque migliorato per una sorta di effetto placebo, in quanto indossando la fascia gli studenti avevano ammesso di sentirsi maggiormente in dovere di mantenere l'attenzione.
Che cosa è cambiato da allora
Da quell’esperimento, che aveva suscitato un acceso dibattito internazionale, molte cose sono cambiate. Negli anni successivi la Cina ha continuato a investire massicciamente in progetti di intelligenza artificiale applicata all’istruzione, ma le fasce EEG hanno lasciato il posto a sistemi più sofisticati e meno invasivi: telecamere con riconoscimento facciale in grado di rilevare emozioni e livelli di concentrazione, software che monitorano i tempi di risposta e l’andamento del rendimento, piattaforme capaci di proporre materiali didattici personalizzati sulla base dei progressi individuali. Parallelamente, in Occidente la discussione si è spostata soprattutto su questioni etiche: la privacy degli studenti, il rischio di sorveglianza costante, l’impatto psicologico di strumenti che trasformano l’aula in un laboratorio di tracciamento.
Se da un lato la ricerca ha confermato che la presenza di dispositivi di monitoraggio può incentivare l’impegno e la disciplina, dall’altro è emersa con forza la preoccupazione che questi sistemi alimentino un modello educativo orientato più al controllo che alla crescita critica degli alunni. Inoltre, il miglioramento tecnologico non ha eliminato del tutto i problemi di attendibilità: anche i software più avanzati continuano a basarsi su interpretazioni statistiche di segnali complessi, che possono portare a valutazioni imprecise o addirittura fuorvianti. Per trovare un'alleata nell'Intelligenza Artificale a scuola è necessario integrarla alle materie e insegnare agli studenti come utilizzarla (su questo anche Fondazione Media Literacy propone dei corsi per studenti e insegnanti), senza che ci sia bisogno di trasformarla in un inquietante strumento di controllo ossessivo.