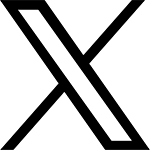“Professoressa, io avrei come docente del corso la Rossi ma …” “Alt! Si dice Rossi non la Rossi. Il suo è un uso sessista della lingua”.
Alle elementari si insegna la democrazia ateniese sottolineando che gli Ateniesi avevano diritto di voto, alle medie che gli Ateniesi liberi accedevano all’assemblea, solo i più fortunati scoprono al liceo che questo fantomatico diritto era negato a circa metà della popolazione: donne, non ricchi e stranieri. Che lo si voglia o meno, come fa notare Alma Sabatini ne Il sessismo della lingua italiana, riprendendo l’ipotesi Sapir-Whorf, la lingua non solo incarna la nostra visione del mondo, ma la condiziona e ce la impone. In assenza di indicazioni ulteriori messe a disposizione da un libro di testo o dall’intervento di un maestro, una maestra, un professore o una professoressa, il bambino e la bambina cresceranno pensando che la democrazia greca sia la stessa nostra democrazia, saranno adulte e adulti privi dei mezzi per disambiguare il testo e così la realtà.
La segnalazione della docente, ascoltata a fine di una lezione in università, va ben oltre la comica e petulante perizia di un’esperta. Lo studio della lingua, soprattutto quella parlata, non può più permettersi di ignorare il fronte di genere e di questo, chi sviscera quotidianamente le trame delle parole, è ben consapevole. L’insegnamento non riguarda tanto il riferimento all’erroneo accostamento di articolo e nome, quanto all’invito da una professoressa alla sua studentessa di non considerare una professionista meno di un professionista e così sé stessa meno di un suo collega di corso.
Questione di titoli
Per donne e uomini che rivestono un ruolo di rilievo, che sia in politica, nella cronaca, nella vita sociale e culturale, la lingua offre forme diverse di riconoscimento. Al maschile una posizione socialmente elevata viene espressa con il solo cognome Pirandello, meno spesso con nome e cognome Luigi Pirandello. Le donne, invece, con il proprio nome Virginia per dire VirginiaWoolf, con il solo cognome preceduto dall’articolo femminile determinativo la Morante o indicante nome e cognome Elsa Morante. Non raramente si nota l’uso di signora davanti a nomi di donne note, come la Signora Thatcher, è una consuetudine più che mai arbitraria, dal momento che per l’uomo non si ricorre mai all’appellativo signore, ritenuto socialmente sminuente.
Chi parla ha incoscientemente metabolizzato che per l’uomo si ricorre a titoli professionali e onorifici. Dall’altra parte invece, esiste una distinzione tra signora e signorina, in cui il senso dietro è la sociale accettazione di un mondo femminile diviso tra donne sposate e meno. Questo un binomio che non ha un equivalente nel mondo maschile, che assegna tuttavia a signorino un tono prettamente umoristico. Il gioco semantico suggerisce che il ruolo di una donna di potere è sempre percepito come più vicino a quello di chi la pronuncia; titoli che per quanto elevati, risulteranno sempre più docili e più famigliari.
Virginia Woolf è per chiunque sempre Virginia: una scrittrice ma prima una donna. Pensando a Pirandello, Joyce, Pessoa nessuno antepone mai la sua appartenenza al genere maschile alla professione, gli scrittori sono prima di tutto scrittori e non amici dei lettori e delle lettrici. In questo scambio di ruoli, la professionista perde il suo valore sociale da tale e viene inserita nel quadro comune femminile: chi pronuncia Virginia si rassicura di star facendo riferimento a una qualsiasi donna che, in quanto donna, è vicino al suo pubblico, lo ascolta e accoglie. La letteratura propone un canone di scrittrici espressione di intimismi, diari, autobiografie e romanzi del cuore, che non ha mai dato loro la possibilità di rivalsa. Dinamica simile quando non si parla mai di Morante ma sempre della Morante. La tendenza è entrata in uso nel momento in cui al novero dei professionisti si aggiungono professioniste, ma ancora a fatica lo accettiamo. La è un articolo determinativo e per sua natura specifica qui un genere, quello femminile, e un numero, il singolare. La Morante, così facendo, è donna, è scrittrice donna, è professionista donna, è lei proprio quella donna, prima di essere Morante.
Il terzo esempio che avevo riportato riguarda l’uso di Signora. I nomi delle donne appaiono per la prima volta su carta sempre accanto al nome di un uomo: si pensano, si scrivono e si leggono come accompagnamento a un nome con genere dichiaratamente maschile. E non è una questione di soli sostantivi ma anche di verbi, che sono i tasselli fondanti del discorso, del linguaggio e così della realtà. In latino il verbo sposarsi si presenta in una duplice forma a seconda che si riferisca all’uomo come soggetto dell’azione o alla donna come potenziale soggetto. Potenziale perché, se da una parte esiste nubeo, ovvero sposo, dall’altra invece esiste uxorem ducere, propriamente condurre una donna -si sottintende in matrimonio. Nel primo caso l’uomo è protagonista dell’azione di scegliere e portare in casa una donna, nell’altro si tratta di un’azione che è riferita alle donne ma che dalle donne non è eseguita, e così, se volessimo tradurlo come a loro riferito, dovremmo usare per forza una forma passiva, ovvero subire l’azione: essere portata in sposa. Essere tenute accanto a uomini è un’azione di stato che ha corrotto anche la lingua ma che questa stessa non smette di convalidare. Dissimmetrie di genere della stessa categoria sono le forme di identificazione della donna attraverso l’uomo, l’età, la professione e il ruolo. Quando viene presentata una coppia, il femminile è sempre in seconda posizione: Professor Rossi e signora, l’avvocato Neri e signora e in molti casi la signora è altrettanto nota o ignota del marito. Nella lista rientrano i patronimici, applicati a padri più o meno conosciuti. In ogni caso l’identificazione femminile avviene attraverso l’uomo e il suo ruolo di moglie, fidanzata, figlia, attributo generico che sia.
L'ambivalenza della lingua
Accanto a questi esempi esistono altri casi in cui la lingua dimostra quanto sia stata avvelenata dal binarismo di genere del nostro metodo di analisi della realtà. La semantica di alcuni aggettivi e sostantivi è perfettamente polarizzata e questi acquistano significati diversi a seconda che si riferiscano a donne o uomini. Libero se riferito a un uomo ha connotazioni morali e intellettuali, se riferito a donna connota un comportamento sessuale; serio è un uomo dalla dirittura morale e coscienzioso sul piano lavorativo, la donna seria è accorta sessualmente e coscienziosa nelle sue doti materne. Carino riferito a un uomo ne connota il comportamento gentile, gradevole, garbato; carina per una donna connota quasi sempre il suo fisico. I sostantivi non sono esclusi da queste dicotomie: maestro da un lato e maestra dall’altro, hanno un significato simmetrico quando si riferiscono all’insegnamento nella scuola elementare, ma per l’uomo, maestro è un sinonimo di magister vitae e miglior fabbro, mentre per la donna la nota nobilissima manca.
Anteporre l’attenzione sull’essere donna all’essere figura professionale è una pratica linguistica sminuente e banalizzante. Caso più grave quando il tono del discorso riferito alle donne è emozionale o superficiale, forzato nelle sfumature, ammiccante, insinuante o condiscendente. I mass media, nella loro naturale alterazione di intenti autoriali, hanno velocizzato lo slittamento del peso del discorso sulla femminilità, lasciando completamente da parte messaggi, notizie e ruoli nella società.
Raccomandazioni all'uso
È la stessa Alma Sabatini nella sua ricerca a proporre ai parlanti delle accortezze linguistiche concrete, per superare le forme sessiste di una lingua prima di tutto androcentrica perché creata da uomini. Per quanto riguarda l’uso generico del maschile neutro, o sovraesteso:
- Evitare l’uso delle parole uomo e uomini in senso universale. Possono essere sostituite da: persona/e; essere/i umano/i; popolo; popolazione. Anziché “i diritti dell’uomo” si puòusare l’espressione “i diritti umani”;
- Evitare di dare sempre la precedenza al maschile nelle coppie oppositive uomo-donna: non dire sempre fratelli e sorelle, bambini e bambine, uomini e donne ma alternare sorelle e fratelli con fratelli e sorelle, bambine e bambini con bambini e bambine;
- Evitare le parole: fraternità, fratellanza, paternità quando si riferiscono a donne e uomini. Utilizzare la solidarietà tra nazioni può essere un’alternativa;
- Evitare di accordare il participio passato al maschile, quando i nomi sono in prevalenza femminili. Si può accordare con il genere largamente maggioritario o, qualora non fosse possibile stabilire il genere maggioritario, con il genere dell’ultimo sostantivo della serie.
Per l’uso non equo di nomi, cognomi e titoli:
- Evitare di riferirsi alla donna con il primo nome e all’uomo con il solo cognome o con nome e cognome;
- Abolire l’uso del titolo “signorina”, che non ha un riscontro in “signorino”, ormai in disuso e che non è mai stato usato con lo stesso valore, indicare lo stato civile;
- Evitare il titolo signora quando può essere sostituito dal titolo professionale.
L’atteggiamento più stagnante nei confronti della lingua è pensare che il modo di studiarla e usarla sia un sistema chiuso, che i nuovi significati e i nuovi atteggiamenti nei confronti dei termini e delle strutture minino la sua stabilità. Ai corsi di linguistica, tra i primi maestri, si studia chi nell’Ottocento aveva già capito che la lingua è un organismo vivente in continua crescita e cambiamento, che nasce e muore ma non è mai fermo, esattamente come le e i parlanti che rappresenta. L’appello è sempre alla sensibilità di chi scrive o parla, al prendere coscienza di ciò che le parole possono fare. Cosa un sostantivo ha fatto e fa alle donne, come un verbo le può emarginare, ridurre e ridicolizzare, sono l’unico punto di partenza per trovare una nuova lingua più rispettosa dell’identità femminile.