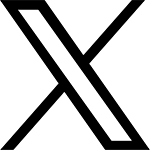In un contesto politico e sociale che non esenta nessuno dall'esposizione alla tragicità contemporanea, sembra che torni per ricavarsi lo spazio che gli spetta quel sentimento inedito, già conosciuto con la fine della seconda guerra mondiale: l'indignazione popolare. Questa cresce di pari passo alla scarsa forza dimostrata dal valore delle norme internazionali. La condanna morale e collettiva degli scenari di guerra a cui assistiamo quotidianamente, difatti, viaggia a velocità decisamente più rapide della prassi giuridica. Tutto ciò rende ormai impossibile non interrogarsi sull'effettiva valenza pratica delle norme internazionali, nel quadro dei tentativi di risoluzione dei conflitti e del mantenimento della pace. Un tale sentimento non fa altro che aumentare il distacco, già esistente, tra il popolo e il sostrato giuridico a cui questo fa riferimento, rendendo inaccessibile per molti una facile comprensione dei motivi per cui, la legge, non riesce a scendere in piazza e gridare "stop al genocidio".
Scrive Sartre nel suo testo “On Genocide” - Il genocidio è un crimine contro l’umanità intera, poiché attacca l’idea stessa dell’uomo, negando a un popolo il diritto di esistere – e questo è il senso che diamo alla nostra indignazione, al nostro fallimento, al nostro sentirci tutte vittime. Ma diverso è l’equivalente giuridico del termine, da intendere come atto la cui peculiarità risiede nel c.d. “dolus specialis”, ovvero nell’intento specifico e verificabile da parte di uno Stato di distruggere un popolo per motivi di razza, religione, etnia o nazionalità. La necessità di provare tale elemento soggettivo rende altamente difficile pervenire alla definizione di genocidio, sistematicità rilevata in casi come quello del Rwanda o in Bosnia; sistematicità che, ai tempi della Germania nazista, non aveva nemmeno un nome, tanto da non riguardare i processi postumi, come Norimberga o Tokyo. È solo nel 1948 che la denominazione inizia a stanziare nei testi giuridici e in particolare nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio e, dagli anni 90, nelle prime sentenze dei tribunali istituiti ad hoc, come il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (TPIY); fino a giungere, nel 2007, alla prima sentenza della CIJ per quanto riguarda la condanna del genocidio in Bosnia.
Lo scontento si inasprisce all’infittirsi delle oscurità governative del nostro paese che è, ormai evidentemente, complice di quanto accade. Un paese che fatica a pronunciarsi con orrore, che si astiene dal votare per la tregua a Gaza in Assemblea Generale ONU, che continua a non volere riconoscere l’esistenza di uno stato che già, de facto, esiste dignitosamente. Un paese che si affianca a chi usa il potere di veto come strumento per bloccare la giurisdizione vincolante del Consiglio di Sicurezza, passaggio che supererebbe l’immobilismo pragmatico giuridico. Un paese che sembra ignorare anni di assedio e morti civili le quali, nei territori occupati dal 1948 ad oggi, raggiungono la soglia dei 100mila secondo stime ufficiali.
A gennaio 2024 la CIG, dopo l’accusa di genocidio sollevata dal Sudafrica nei confronti del popolo palestinese nella striscia di Gaza da parte di Israele, ha emesso misure provvisorie, non ancora tradotte in sentenza pur rappresentando un momento di svolta cruciale. La reazione internazionale di paesi come la Spagna è stata forte: accogliere la decisione e approvare, nel settembre 2025, un decreto-legge con il quale si prevede l’embargo totale di armi verso Israele. Nel nostro paese, non è stato mosso un dito. Gli accordi commerciali restano, gli aiuti militari pure.
L’indignazione popolare è dunque comprensibile dal momento in cui si realizza che, dirsi per la pace, non è sufficiente; servono azioni concrete, che non possono attendere l’esasperazione del popolo, al punto di “bloccare tutto” o attraversare il mare.
Il diritto internazionale può essere baluardo di speranza se si accetta di abbandonare le logiche del guadagno, della sottomissione diplomatica e della convenienza, altrimenti quest’ultimo rischia di rimanere un insieme di norme inattese e tradite in partenza rispetto al loro scopo. La legge non può ancora spingersi oltre i limiti della prassi che necessariamente la connota e farsi compagna di chi condanna il genocidio in corso, ma è essenziale per tracciare i confini del silenzio e della complicità. Nel mondo che viviamo oggi, nessun conflitto è territorialmente recintato: assistiamosolo a quella che è una parcellizzazione del conflitto più grande, la cui soluzione è auspicabile solo in un ordine giuridico, appunto, più ampio. Uno strumento che, dunque, va rafforzato e valorizzatoaffinché la sua utilità non resti illusoria.