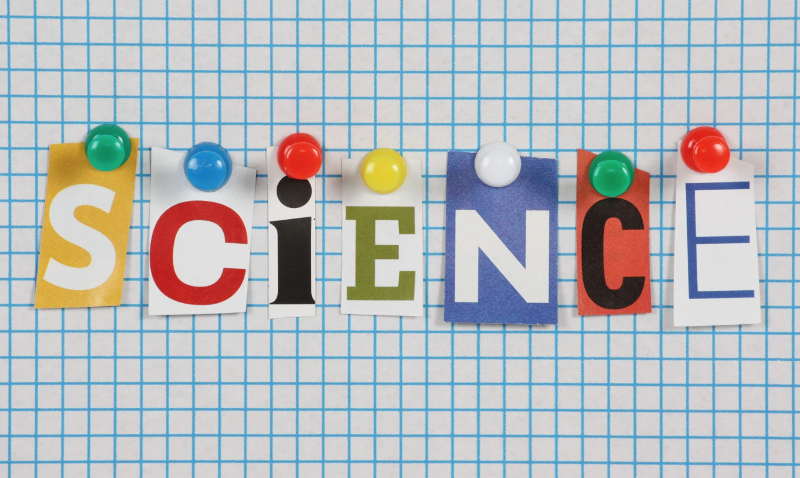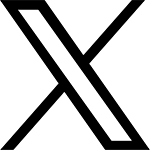Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: un documento storico che sancisce i diritti e le libertà fondamentali di ogni individuo. L’art.27 afferma: “Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici”. Questo passaggio sottolinea il diritto di ogni persona non solo di accedere ai risultati scientifici, ma anche di contribuire attivamente al progresso della scienza.
Negli ultimi decenni l’interpretazione del diritto alla scienza si è ampliata: inizialmente si focalizzava sulla libertà degli scienziati di condurre ricerche e sul diritto del pubblico di accedere ai risultati; tuttavia sono emerse questioni etiche, come il potenziale conflitto tra la ricerca e i diritti delle comunità coinvolte. Ad esempio, la costruzione di laboratori o la raccolta di dati potrebbero minacciare il patrimonio culturale di determinate popolazioni. Pertanto è essenziale che la ricerca sia condotta nel rispetto dei princìpi di equità, giustizia e bene comune.
Farida Shaheed, ex relatrice speciale ONU per i diritti culturali, ha evidenziato come il diritto alla scienza e il diritto alla cultura siano interconnessi: entrambi implicano la possibilità per le persone di riconsiderare, creare e contribuire ai significati culturali e alle espressioni della società. Questo approccio promuove un ethos di ricerca guidato dall’immaginazione e dalla curiosità, elementi chiave per affrontare le sfide attuali.
Il diritto alla scienza è più di una semplice clausola legale: rappresenta un invito a tutti noi a essere curiosi, a partecipare attivamente al progresso e a contribuire alla costruzione di una società più equa e sostenibile. Riconoscendo e valorizzando questo diritto possiamo affrontare con maggiore efficacia le sfide globali e promuovere un futuro in cui la scienza sia al servizio di tutta l’umanità.