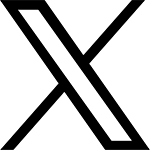Recentemente Netflix ha rilasciato il film “Il mio anno a Oxford”, una commedia romantica che vede come protagonista Anna, una giovane americana con già un futuro scritto ma che ha deciso di mettere in pausa i suoi piani per un anno e frequentare un corso di poesia all’Università di Oxford. Il film, online da poco, è già sulla bocca di tutti per il suo finale: sì perché a differenza del libro dai cui è tratta la storia (che si chiude con un finale ricco di speranza e più che felice) il film ha lasciato tutti in un mare di lacrime con un epilogo non esattamente gioioso. Perché cambiare il finale di una storia già scritta e renderla drammatica? Forse perché i finali tristi, per un motivo o per l’altro ci piacciono di più.
La catarsi greca
I greci furono i primi a intuire la risposta: già nel quinto secolo avanti Cristo Ippocrate, cultore della medicina, parlava di una parola dal significato originale sicuramente meno creativo e spirituale di quello che pensiamo oggi: catarsi. Nel suo caso si trattava letteralmente di una “processo di purificazione” dato da una purga molto forte indotta con metodi naturali o con farmaci. Insomma, si trattava della purificazione del corpo attraverso l’evacuazione; anche le mestruazioni di una donna erano considerate un esempio di catarsi, così come (strano a dirlo ma vero) tagliare i rami degli alberi affinché ne crescessero di nuovi e più robusti.
Una prima sfumatura di significato per come lo conosciamo noi oggi ce la regala Platone: per lui la catarsi era quel processo di liberazione dell’anima dalle impurità e dai peccati del mondo sensibile per avvicinarsi alla purezza mondo delle idee. La vera svolta per come conosciamo noi il termine oggi arriva qualche secolo dopo; dalla medicina si passa al teatro, d’altronde si dice che a volte non ci sia medicina più potente dell’arte: “la tragedia mediante una serie di casi che suscitano pietà e terrore, ha per effetto di sollevare e purificare l'animo da siffatte passioni” così diceva Aristotele nell’opera Poetica. Attraverso le emozioni intense che proviamo osservando le vicende tragiche purifichiamo la nostra anima fino a una liberazione totale da cui traiamo sollievo.
I nuovi studi psicologici
I greci in effetti ci erano andati abbastanza vicini, a dimostrarcelo è uno studio dell’Ohio State University condotto nel 2012 dalla professoressa di comunicazione Silvia Knobloch-Westerwick. Durante l'esperimento 361 studenti universitari hanno guardato una versione ridotta del film Espiazione, noto per il suo tono drammatico, e sono stati sottoposti in seguito alla visione a un questionario psicologico per misurare diversi aspetti, come il loro livello di tristezza, le riflessioni generate dalla visione e il loro senso di apprezzamento della vita e delle proprie relazioni personali.
Il risultato è stato spiazzante: più il livello di tristezza era elevato, più gli studenti erano portati a riflettere sulla vita infine a provare un senso di gratitudine per non trovarsi nella stessa situazione dei protagonisti del film. "La tristezza del film fa sì che i partecipanti pensino alle loro relazioni significative, il che a sua volta aumenta la felicità. Non è la tristezza in sé a portare felicità, ma ciò a cui la tristezza ci conduce", conclude la professoressa.
Quindi, se siete tristi e avete voglia di vedere un bel film divertente per riprendervi, la prossima volta considerate invece l'idea di guardare un film drammatico: sembra che dopo apprezzerete di più la vostra vita.